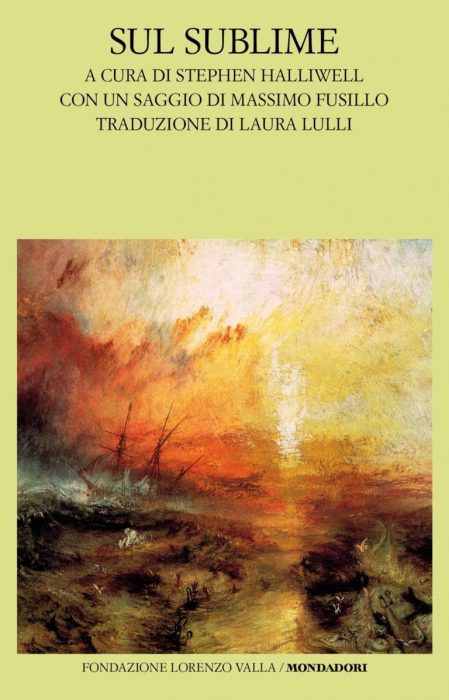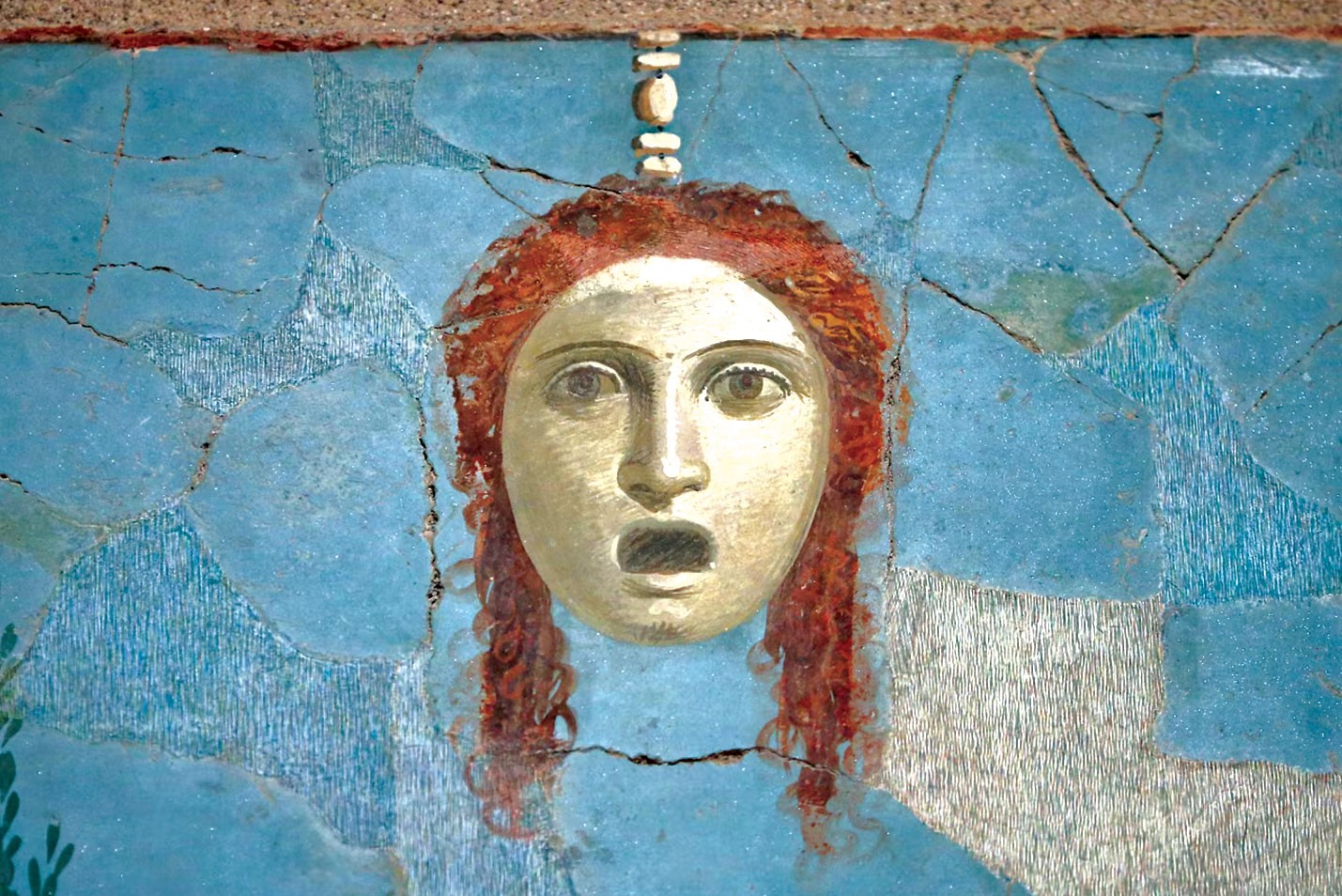Barbara Castiglioni, Il Giornale
«Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: e il naufragar m’è dolce in questo mare». Gli immortali versi che chiudono l’Infinito di Leopardi possono essere considerati un manifesto del concetto di sublime, o di quello che, nel corso dei secoli, il sublime è venuto a significare.
Scritto nel primo secolo da un retore greco che si è provato a identificare con Dionisio di Alicarnasso o Cassio Longino, il trattato del Sublime è rimasto di autore ignoto, accrescendo ancora di più il fascino di un’opera seconda solo alla Poetica di Aristotele per l’influsso esercitato, come spiega Halliwell nell’introduzione alla nuova, maestosa edizione pubblicata ora dalla Fondazione Valla (Mondadori, pagg. 543, euro 50). Da Platone ad Orazio, da Michelangelo al «piacere frammisto di terrore» di Kant a Goethe, passando per il «dilettoso orrore» di Burke, da Bach a Friedrich e al suo mare di nebbia, da Schopenhauer a Schiller al «sublime in basso» di Victor Hugo fino al modernismo, che «conosce solo il primo tempo del sublime – lo smarrimento e l’annientamento del sé – ma non la sua riconfigurazione razionale», come sosteneva a ragione Weiskel, ricordato da Fusillo nel suo corposo saggio introduttivo, il sublime è stato discusso e inseguito in ogni fase della storia. Ma com’è possibile che uno scritto di retorica, concepito come una risposta polemica ad un omonimo trattato di Cecilio di Calatte, sia diventato un testo cardine della riflessione estetica dell’Occidente? Forse per l’ostinato rifiuto, da parte dell’autore, del contraffatto, dell’art pour art, nella convinzione che solo una grande anima, e non chi ha pensieri meschini, possa arrivare al sublime. O per l’idea che all’ispirazione dell’oratore – o dell’autore – debba corrispondere l’emozione di chi ascolta. O per gli slanci metafisici («se si guardasse complessivamente alla vita, considerando quanto la straordinarietà, la grandezza e la bellezza siano superiori in ogni cosa, si capirebbe subito per quali scopi esistiamo»), a cui si accompagna la straordinaria – e modernissima – intuizione che possa esistere un’armonia dissonante, «un ordine disordinato». Perché, in fondo, «il sublime distrugge tutte le cose come un fulmine» e una genialità «che non bada alle minuzie» deve essere sempre preferita all’infallibilità senza sussulti: certo, Apollonio Rodio si rivela un poeta infallibile, scrive l’Anonimo, «ma tu vorresti essere, al dunque, Omero o Apollonio?».