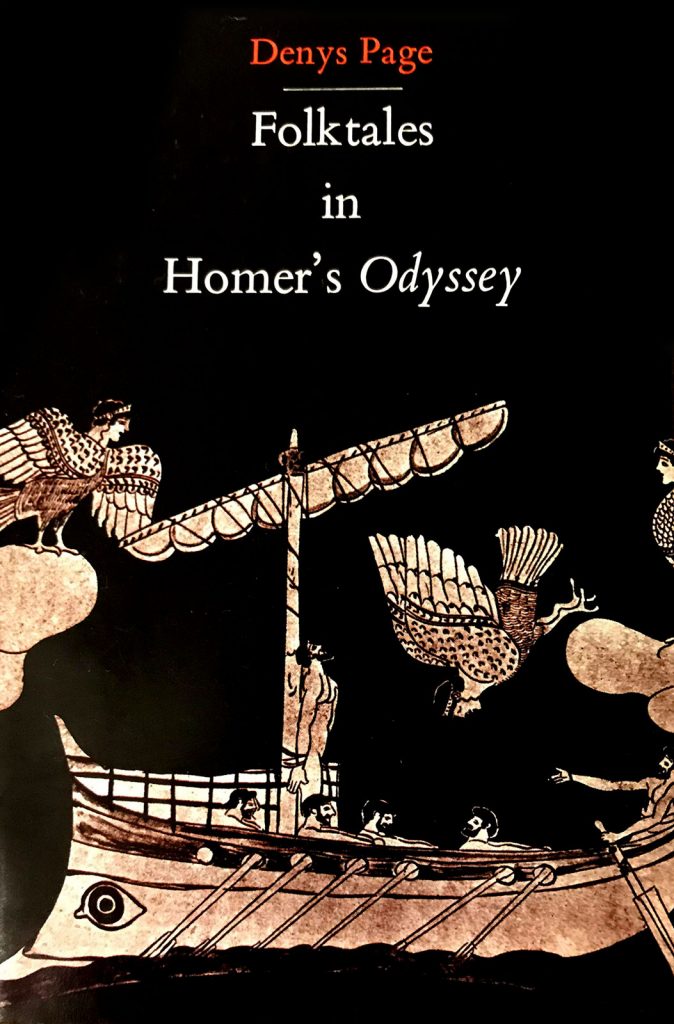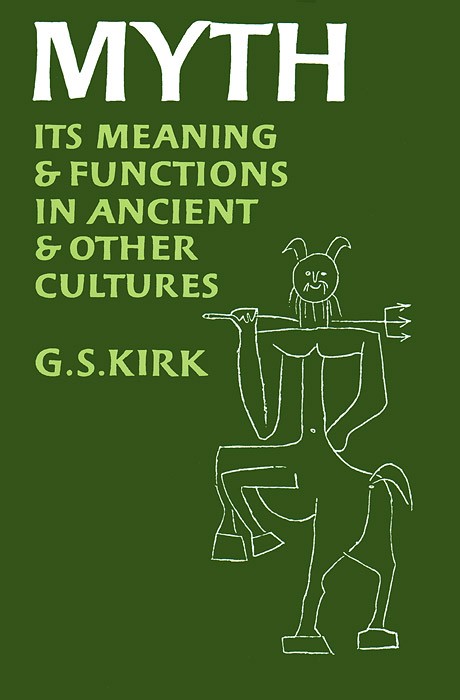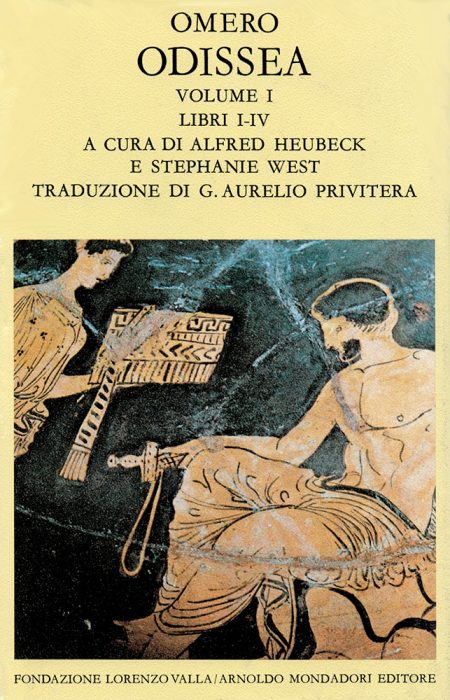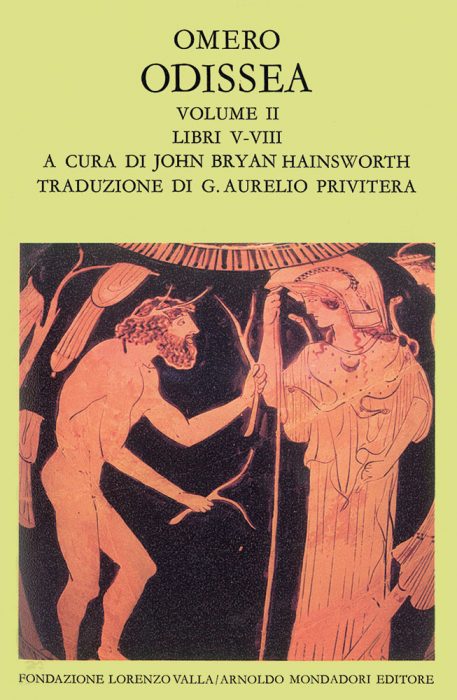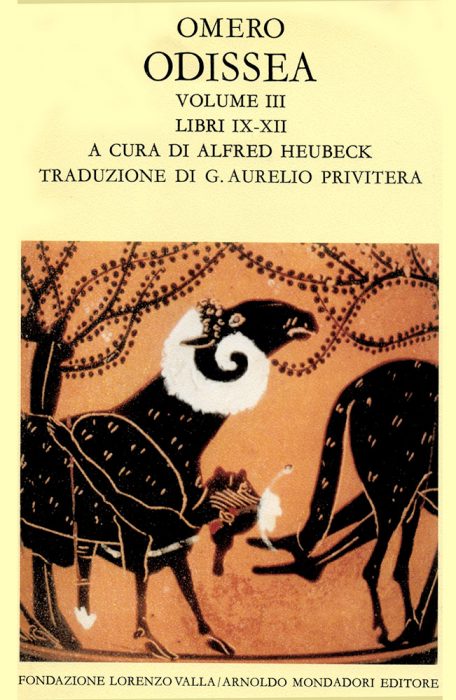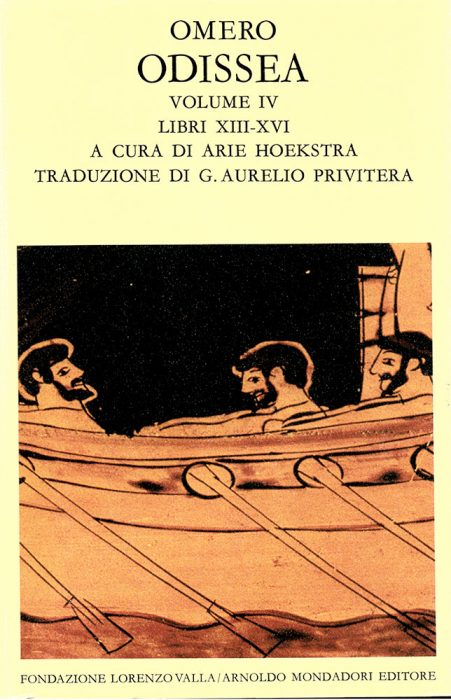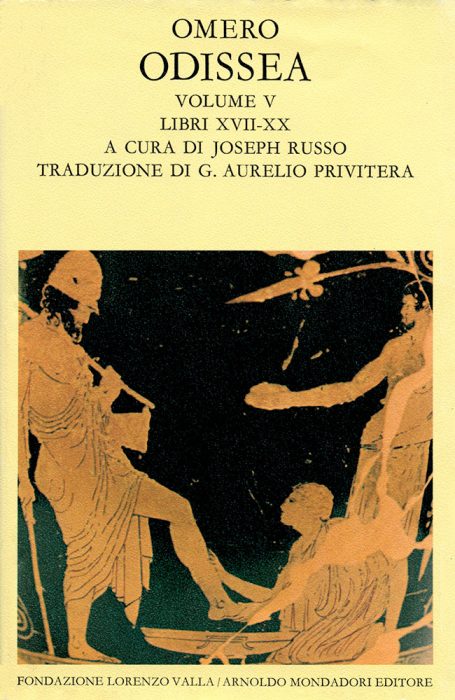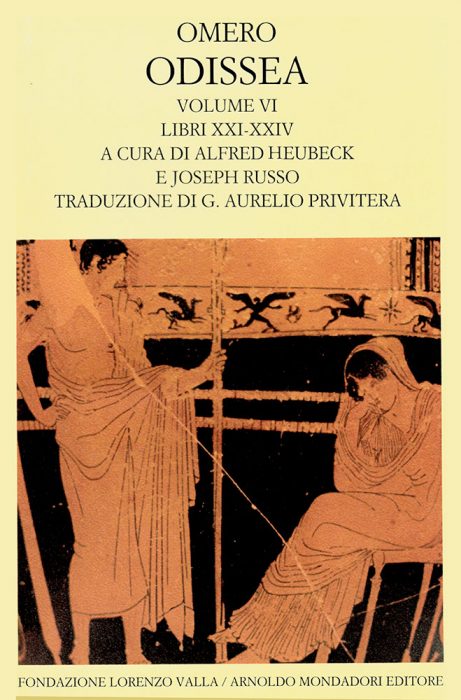I poemi omerici appartengono ad una dimensione altra rispetto al mondo della scrittura a tavolino: composti in uno stile formulare e non esenti da incoerenze cronologiche e logico-narrative proprie dell’oralità, sono stati talvolta sottoposti dalla critica a un’eccessiva dissezione analitica nell’illusorio miraggio di poter infine recuperare la loro miracolosa genesi. Tuttavia certo lo stesso Milman Parry, che ha sottolineato la non omologabilità delle forme ed espedienti retorici e poetici tra l’epica orale e quella scritta, in maniera particolare, a proposito delle similitudini, non sarebbe stato d’accordo a frantumarli esclusivamente in microcontesti tematici o formulari, astraendoli dal canone poetico di tipo tradizionale della cultura occidentale. Sia nell’Iliade sia nell’Odissea, per quanto si tenti spesso di negarla, compare una concezione estetica unitaria e funzionale, in virtù della quale i poemi di Omero possono a buon diritto essere ritenuti i più antichi e i più grandi capolavori della letteratura mondiale. Quando si è dismesso l’accigliato cipiglio dello scienziato, il testo di Omero diventa quindi un’esperienza di lettura molto più complessa e profonda. A deporre tra gli altri l’animus dell’altero filologo che pure era, fu tra gli altri, Sir Denys Page, Regius Professor of Greek all’Università di Cambridge, che nelle sue Lectures tenute in una visita ad Harvard del 1972, seleziona alcuni episodi dell’Odissea proponendone bellissime interpretazioni in chiave folklorica; esse saranno poi raccolte nel volumetto Folktales in Homer’s Odissey2 (1973), tradotto in italiano nel 1983 col titolo Racconti popolari dell’Odissea; qui Page deve senza dubbio ad un altro lettore di Omero G. S. Kirk col suo Myth. Its Meaning and functions in Ancient and others Cultures3, (Cambridge 1970) citato nell’incipit del volumetto.
Il Regius Professor convinto assertore della persistenza di racconti folklorici nell’Odissea, trattati in maniera da diventare credibili e, quindi, accettabili per l’uditorio contemporaneo, si lascia però soprattutto trasportare dal piacere del racconto e del raccontare. Non è solo Sir Denys Page a leggere così l’Odissea. Alfred Heubeck, nell’introduzione generale all’Odissea per la Lorenzo Valla, come scrisse Italo Calvino all’uscita del volume su Repubblica (21 ottobre 1981), ha individuato la grande novità dell’Odissea e del suo protagonista: «Gli eroi dell’Iliade agiscono in uno spazio geografico che l’uditorio conosceva per diretta esperienza; essi vivono in un mondo che ha caratteristiche umane, nel bene come nel male. Ma Odisseo, dopo la tempesta a capo Malea, ha valicato i confini di questo mondo reale e, dopo il superamento di questa barriera viene a trovarsi in un mondo in cui le coordinate dell’eroico e dell’umano non sono più valide. È vero che anche al di là di questo confine, che per i più resta per fortuna invalicabile, esistono mari, terre e isole, e che anche lì valgono gli stessi punti cardinali, ma in questo mondo diverso esistono esseri e figure che la ragione umana non può concepire e che si sottraggono ad ogni esperienza. È il mondo del fantastico e dell’immaginario, dell’irrazionale e dell’irreale, della magia e dell’incantesimo, che non è in alcun rapporto commensurabile con il mondo dell’esperienza ed i cui elementi … sono stati esclusi dall’epica arcaica, al più tardi dal poeta dell’Iliade, restando percepibili solo in pochi oscuri relitti … È significativo – conclude poi Heubeck – che il poeta faccia raccontare le sue peregrinazioni all’eroe proprio davanti ai Feaci, cioè davanti ad un popolo che svolge la funzione di tramite tra i due mondi».

L’Odissea è dunque incentrata sul racconto e sulla ricerca di un racconto di un viaggio di ritorno che tutti vogliono o vorrebbero conoscere, ma solo Ulisse, il protagonista, potrà, arrivato o quasi alla sua meta raccontare, in modo che possa costituire oggetto di canto per gli aedi. Ulisse narra però come meglio crede i suoi viaggi a seconda di chi ha di fronte: ai Feaci fa racconti fantastici che seguono la rotta delle avventure effettive e sono popolati di personaggi irreali e fiabeschi, ad altri, ai quali intende dissimulare per il momento la sua vera identità, fa a volte racconti menzogneri ma che appaiono al lettore e agli interlocutori molto più realistici e credibili. Eratostene di Cirene, ironizzando sull’itinerario di Ulisse, scommetteva che lo si sarebbe conosciuto solo quando si sarebbe trovato l’artigiano che aveva creato l’otre dei venti di Eolo.
Ma Stephanie West, facendo eco alle osservazioni di Heubeck, nell’introduzione alla Telemachia, evidenzia che esisterebbe un racconto alternativo di nostos implicito nell’Odissea, oltre a quello fatto ai Feaci da Ulisse sul suo incontro in successione con i Ciconi, i Lotofagi, Polifemo, Eolo, i Lestrigoni, Circe, sull’arrivo in Trinacria, e, infine, sulla lunga sosta da Calipso; esso sarebbe appunto quello costituito appunto dall’insieme dei racconti menzogneri, ma più vicini alla realtà, che di volta in volta l’eroe inventa per Atena nel 13 libro, per Eumeo nel 14, per i Proci nel 18 e per la stessa Penelope nel 19: la fuga da Creta, la prigionia in Egitto, l’approdo in Tesprozia nel tentativo di tornare a Creta. Nell’ultima versione del falso racconto destinato a Penelope, prima del riconoscimento, Ulisse, sotto le spoglie del mendicante, riferisce addirittura di essersi imbattuto in se stesso e che Ulisse avrebbe fatto al mendicante (cioè a se stesso) il racconto del proprio nostos, il quale avrebbe avuto come tappe successive la Trinacria, Scheria, la Tesprozia e Dodona. Ma Ulisse ancora nel canto 8 pregando come supplice Nausicaa fa riferimento anche ad un suo viaggio a Delo, laddove solo avrebbe scorto un virgulto di palma (l’albero sacro dell’isola) paragonabile per beltà alla fanciulla. La sua sosta a Delo fa parte integrante certo a livello locale della tradizione epica: nell’Inno omerico ad Apollo l’io narrante incarica le fanciulle di Delo di rispondere proprio ad uno straniero, il quale, dopo molto avere sofferto (ξεῖνος ταλαπείρος = Ulisse?), sia giunto da loro a chiedere chi sia l’aedo più bravo che il cantore che le allieta di più è il cieco che abita nella rocciosa Chio. Dunque questo nostos, che si ricostruisce dai racconti di Ulisse esterni agli apologhi rivolti ai Feaci, dovrebbe costituire l’itinerario vero del viaggio, se mai sia possibile supporne uno che sia originario; in seguito questo percorso di viaggio sarebbe stato modificato e poi sarebbe andato sempre più sviluppandosi fino ad articolarsi per diventare quello che conosciamo, popolato di figure e di avventure fantastiche, immaginabile tuttavia come collocato in mari ancora non del tutto esplorati per quei tempi e poco conosciuti, al di fuori della nozione omerica vulgata di Oceano e dei suoi confini. Ma perché un racconto si trasformi in un altro così diverso, con una rotta geografica e una storia ‘alternativa’, ci deve essere un motivo funzionale, di tipo storico o letterario. E se non fosse così? O se non fosse così semplice individuare un fenomeno di trasformazione di un racconto di nostos in un altro? e se il concetto stesso di racconto alternativo in cui sostanzialmente una narrazione esclude l’altra e nessuna delle due può esistere in contemporanea, legato agli studi dell’oralità comparativistica, non potesse essere applicato tout court in questo caso all’Odissea?
Abbandoniamo per un momento l’Odissea e guardiamo, come Kirk e Page, all’antropologia culturale. Di poesia orale, poesia folklorica e poesia popolare, si è molto occupato un grande studioso italiano scomparso da diversi anni, Eugenio Cirese. Poesia orale e popolare o folklorica si contrappongono nella concezione di Cirese solo in compresenza socio-culturale della scrittualità; ossia, nei popoli e nelle fasi storiche ‘senza scrittura’, dove cioè non c’è compresenza dei due mezzi tecnici di materializzazione e di conservazione ‘letteraria’, l’oralità in queste circostanze non è connotato di popolarità. Metodologicamente pertanto non sarebbe neanche del tutto errato applicare alcuni meccanismi linguistico-letterari operanti nella poesia popolare alla poesia orale greca antica, e, in particolare all’Odissea, che dal folklore non può nei suoi racconti fantastici prescindere. In un saggio, che risale al 1968 dal titolo ‘Il mare come segno polivalente’, compreso nel volume Ragioni metriche (Palermo 1988), Eugenio Cirese ha indagato il significato del segno linguistico ‘mare’ nei Canti toscani raccolti da Niccolo Tommaseo nel 1841, servendosi anche di raffronti esterni a questa antologia. I risultati sono molto interessanti: il mare a volte è connesso col rischio e la separazione e individua un mare reale, mentre altrove il mare è collegato a circostanze del tutto irreali e a sentimenti soggettivi e personali, quasi sempre di tipo sentimentale. Ma c’è di più. Quando si ha a che fare con lo stereotipo linguistico ‘In mezzo al mare c’è’, ecco in mezzo al mare ci può essere qualsiasi cosa, una colonna, una balena, un pesce tondo, una pianta d’uva, una palla d’oro; l’incipit è quindi un segnale linguistico specifico che introduce l’uditorio direttamente nel mondo della fantasia e dell’astrazione.
Se volessimo trasportare questo schema interpretativo ai due nostoi odissiaci, forse alla luce dell’antropologia, come hanno fatto pure Page e Kirk, e, anche, senza trascurare il concetto di fiaba che ha introdotto Calvino nel suo saggio-recensione, non si può escludere l’ipotesi che essi non siano né alternativi né, pertanto, successivi: nessuno dei due verrebbe dopo l’altro ed escluderebbe l’altro, sembrerebbero invece due modalità perfettamente coesistenti in quanto rientrerebbero nel valore che il segno-mare può assumere nella poesia folklorica, inglobata in un racconto epico più esteso. A questo punto divertiamoci — ma divertiamoci solo — ad utilizzare questo schema come griglia esegetica per valutare un altro aspetto, quello più adatto ad essere sondato tra i luoghi dell’Odissea, le isole. Vediamo se tale bipolarismo regge anche in questo caso. Partiamo da un’isola ‘reale’: Itaca. In 13, vv. 187-345, Ulisse ritiene di essere stato portato ad Itaca dalle infallibili navi dei Feaci, ma sveglio non riconosce l’isola per volere di Atena che gli ha annebbiato la sua visione ed è disorientato, o forse solo non la riconosce come ognuno che ritorni dopo lungo vagare e veda la sua patria simile ma allo stesso tempo diversa; certo Atena gliel’ha del tutto cambiata e come apprendiamo dalle sue stesse parole resa del tutto simile ad altre isole fantastiche che ha toccato nel suo viaggio:
… Si destò il chiaro Odisseo,
che dormiva nella terra dei padri, e non lo riconobbe la patria,
da cui era assente da tempo: d’una nebbia l’avvolse
la dea Pallade Atena, la figlia di Zeus, per farlo
irriconoscibile e raccontargli ogni cosa,
e non lo ravvisasse la moglie, i cittadini, gli amici,
prima che egli punisse i pretendenti d’ogni loro violenza.
Perciò tutto pareva estraneo al sovrano,
gli ininterrotti sentieri e i porti con ogni approdo,
le impervie rupi e gli alberi lussureggianti.
Si alzò in piedi e guardò la terra dei padri;
poi gemette e con le mani aperte batté
le sue cosce e piangendo esclamò:
«Povero me! nella terra di quali mortali mi trovo?
Forse prepotenti e selvaggi e non giusti,
oppure ospitali e che temono nella mente degli dei?
Tante ricchezze dove posso portarle? dove io stesso
ora vago? oh se fossero rimaste laggiù
dai Feaci! […]
Ahimè, non erano saggi e giusti
del tutto i capi e i consiglieri feaci
che mi portarono in una terra diversa: promettevano
di guidarmi ad Itaca chiara di sole, ma non l’hanno fatto.
[…]
… Ma rimpiangeva la patria,
arrancando sulla riva del mare che molto rimugghia,
tra molti lamenti. Accanto a lui venne Atena,
nell’aspetto somigliante ad un giovane, a un pastore di greggi.
delicatissimo, come sogliono i figli dei principi,
con intorno alle spalle un doppio mantello ben lavorato:
aveva sandali ai morbidi piedi ed in mano una picca.
Vedendola Odisseo gioì e le andò incontro
e parlando le rivolse alate parole:
«O caro, poiché ti incontro per primo in questo paese,
salute! e non accostarti a me con animo ostile,
ma salva queste ricchezze e salve anche me: come un dio
io ti supplico e vengo ai tuoi cari ginocchi.
E dimmi sinceramente anche questo, che io sappia bene:
che terra è, in che contrada, che uomini l’abitano?
È forse un’isola chiara nel sole (εὐδείελος)? o una penisola
del continente dalle fertili zolle reclinata nel mare?».
Gli rispose allora la dea glaucopide Atena:
«Sei sciocco o vieni da molto lontano, straniero,
se di questa terra mi domandi. Non è poi
così ignota: la conoscono tantissimi uomini,
sia quanti abitano verso l’aurora e il sole,
sia quanti abitano dietro, verso il crepuscolo.
È aspra e impervia per i cavalli,
non è troppo magra né vasta.
Vi è grano da non dirsi in essa,
e vino, e sempre v’è pioggia in fitta rugiada.
è buona pastura di capre di buoi e vi è un bosco
con ogni albero e sempre v’è acqua negli abbeveratoi.
Perciò il nome di Itaca è giunto, o straniero, anche a Troia,
che pure dicono sia lontana dalla terra achea».
Disse così, si rallegrò il paziente chiaro Odisseo
gioendo per la sua patria, da come gli disse
Pallade Atena, la figlia di Zeus egìoco.
Ma Ulisse si fida ancora poco e solo quando il gioco di inganni con Atena finisce e la dea si rende riconoscibile e disvela la sua isola per come è veramente, si convince finalmente di essere arrivato alla meta del suo viaggio. Itaca viene più o meno descritta allo stesso modo anche nel libro 9 quando il protagonista dichiara finalmente la sua identità ad Alcinoo e, ancora prima nel libro 4 così ancora è descritta a Menelao da Telemaco. Ulisse dice di abitare ad Itaca isola ‘ben visibile’εὐδείελος e nota a tutti e Telemaco a proposito di Itaca si esprime in termini molto realistici, rifiutando di portare con sé i cavalli che gli ha donato Nestore e preferendo lasciarli a Sparta, perché Itaca è una terra come molte sul mare, la più amata da chi vi abita, ma non adatta ai cavalli, piccola e rocciosa, anche se non è troppo povera. εὐδείελος nel brano appena letto potrebbe essere inteso come se servisse a descrivere il tratto caratteristico dell’isola, i cui contorni sono visibili rispetto ad un terra che faccia parte di un territorio più vasto; però l’aggettivo compare unicamente e sempre solo come epiteto formulare di Itaca nell’Odissea anche altrove (ritorna una sola volta nell’Inno ad Apollo per l’isola di Crise); e Ulisse — ricordiamoci — quando Atena gliene ha occultato la vista reale con la nebbia, dubita di essere approdato nella sua terra Itaca, o in un’isola εὐδείελος; sarà la dea a disvelarla come terra reale e isola nota a tutti, εὐδείελος. Itaca, dunque nell’Odissea, è rappresentata come una terra, un’isola nota, reale, riconosciuta, e riconoscibile, ben individuabile, perché presente nelle tappe e nelle rotte dei marinai, un luogo reale, dove vi si abita, amata, ma dove il sostentamento alla vita lo si ricava con il lavoro, con la coltivazione e l’allevamento, non estesa ma neanche troppo povera.

L’attacco ‘in mezzo al mare c’è’ o una rappresentazione letteraria equivalente è attestata invece per presentare le altre isole, quelle dove avvengono le avventure più fantastiche: ‘in mezzo al mare c’è’ (è proprio riprodotta in greco questa formula) l’isola di Faro in Egitto, che è un’ isola reale ma dove si colloca il fantastico e irreale incontro di Menelao col Vecchio del mare, Proteo; in ‘un’isola’ non altrimenti identificata in termini di coordinate sicure, l’isola di Ogigia, dove è la dimora di Calipso e Ulisse è trattenuto, e dove, persino il messaggero degli dei, Hermes, fatica ad arrivare attraversando una così vasta distesa di acqua salmastra e lo fa solo per ordine di Zeus.

In mezzo al mare c’è l’isola di fronte alla costa della terra dei Ciclopi, l’isola delle Capre, dove approda Ulisse coi compagni, che però stranamente, anche se sembrerebbe un’isola normale come Itaca, non è ben in vista come Itaca, i Greci vi giungono con la nebbia e pur essendo adatta ad essere abitata, con belle insenature per attraccarvi, vi scorrazzano solo animali selvatici: neanche questa isola è umana e reale, poichè la simbologia della nebbia sottolinea l’arrivo o il contatto con un mondo irreale, secondo quanto si è visto prima nel 13 libro.
Nel mezzo al mare c’è anche l’isola di Eolo che è addirittura galleggiante, che non è ancorata di sotto alla terra e vaga nel mare, perciò nel mezzo al mare la si può incontrare, forse, ma non si sa esattamente dove; circondata dall’onda del mare dagli ampi percorsi è anche l’isola di Eèa di Circe; e infine una tempesta dai alti flutti sballotta Ulisse, partito con la zattera dalla dimora di Calipso, dall’isola di Ogigia, per diversi giorni (circa 3, più gli altri di buona navigazione) fino a farlo approdare ad un’altra isola, Scheria.
Anzi la prima volta in cui Scheria viene avvistata, si palesa dal largo ombrosa come uno scudo nel mare (5, vv. 280-1), e poi in un primo momento egli vi viene allontanato dalla tempesta scatenata da Poseidone: anche l’Ulisse di Dante riuscirà a scorgere all’orizzonte il Paradiso terrestre, una montagna bruna per la distanza, prima di essere rapito dai vortici e tagliato fuori per sempre da questo approdo. E chissà se in Dante non ricorra proprio lo schema tipologico sull’isola, prodotto della fantasia di ogni popolo in ogni luogo, senza dover necessariamente chiamare in causa fonti latine, dato che Scheria è descritta pure da Omero come una sorte di Paradiso terrestre, ossia non è sulle rotte conosciute, o per dirla con Gozzano, l’isola Non-Trovata, quella ‘che è la più bella, esiste, appare di lontano, e scivola via sulle onde se ti avvicini, s’annuncia col profumo come una cortigiana’.
Da qualche parte in mezzo al mare, quindi, è l’isola dei Feaci che vivono fortunati e felici lontano dagli uomini mangiatori di pane: Nausicaa nel 6 canto (v. 204 ss.) dice che Scheria si trova lontano dagli uomini ‘in mezzo al mare dall’ampio flutto’. Nell’Odissea, c’è, insomma, già tutta la casistica mitico-letteraria sull’isola della tradizione moderna: per citare Eco il mito dell’assenza (l’isola che non c’è), dell’eccedenza (l’isola che c’è troppo), dell’imprecisione (l’isola mai trovata), e, infine, della perdita (l’isola mai ritrovata).
A questo punto però dobbiamo cioè lasciare questo schema latente di sottofondo di contrapposizione tra Itaca e le altre isole che probabilmente affonda le sue radici nel significato antropologico del segno linguistico mare e che ci è stato utile per distinguere le peculiarità di Itaca, per approfondire quello che è poi diventata davvero nel testo omerico e oltre. Itaca che da piccola e arida, diverrà sede dei canti del nostos di Ulisse, simbolicamente esprime sì la vicenda stessa dell’eroe protagonista, quella di un principe spodestato, destinato poi per il suo valore, dopo una dolorosa sofferenza e molte peripezie, a capovolgere le sue sorti, non senza agire nelle sue imprese con una buona dose di crudeltà sanguinaria come è tipica di molte fiabe. Ma non solo. È nell’Odissea una costruzione letteraria molto elaborata, il cui valore si definisce proprio a partire dal rapporto specifico che s’istituisce soprattutto con altre due isole del mondo irreale, l’isola delle Capre davanti alla terra dei Ciclopi e quella dei Feaci (tra l’altro i Feaci sono contrapposti ai Ciclopi). In tutta la prima sezione del poema, soprattutto nei primi 5 canti, che fungono da anticipazione, Itaca è descritta come il luogo dove, assente il re, non c’è più giustizia, Laerte si è ritirato in campagna per non assistere ai soprusi dei Pretendenti che divorano a torto o a ragione le ricchezze private del re e della sua famiglia, neanche l’assemblea convocata dal giovane Telemaco si svolge con le regolari procedure; lo stesso Telemaco vi giunge armato e ingiustamente si rivolge agli Itacesi che però seguono Antinoo e sciolgono spontaneamente senza reagire l’assemblea. In questo momento Itaca è un’isola selvaggia, priva di regolamenti e di osservanza delle leggi divine e umane. Assomiglia ai comportamenti spietati senza regole che governano la vita ferina presso i Ciclopi, senza rispetto per l’ospitalità, per le norme consuetudinarie umane garantite da Zeus. Non a caso la lunga descrizione dell’isola delle Capre di fronte a quella dei Ciclopi sembra rispecchiare e alludere a quella che potrebbe essere l’immagine di Itaca in altri passi del poema. Scheria, invece, luogo di vita ideale, di giustizia, lontana dagli spazi umani, è la città della musica, della danza, dei racconti epici della tradizione, dell’aedo Demodoco che sa cantare tutto a perfezione come uno che sia stato presente o abbia visto egli stesso; ed è l’isola da dove comincia il reintegro di Ulisse nel mondo reale, non prima però che egli stesso racconti il suo nostos proprio come se fosse un vero aedo a narrarlo. Il suo però è ancora un racconto e non un canto; è ciò che precede il canto, non è ancora epica. È solo ad Itaca dove si sta concludendo per ora la vicenda dell’eroe, perché ci sarà il famoso Ultimo viaggio di Ulisse, celebrato anche da Pascoli, che il racconto di Ulisse, persino il truce e ultimo episodio, con la vendetta e il ripristino della normalità, è, solo qui ad Itaca, che questi apologhi di Ulisse possono diventare finalmente epos, il canto famoso dell’aedo, rinomato per tutti. Il compito di trasformare tutto in epica se lo assumerà un altro cantore, Femio. L’aedo itacese, pur avendo servito i proci sotto costrizione, sarà risparmiato da Ulisse per intercessione di Telemaco, solo perché è in grado di creare canti nuovi, di celebrare hic et nunc al momento le imprese dell’eroe.
Ed è appunto l’immagine di Itaca, terra in qualche modo connessa ad un rapporto di giustizia alterato ma anche terra di canti e di poesia, arida, dura e difficile all’aratro, piccola, tuttavia splendente, che viene consegnata alla tradizione letteraria successiva. Questo insieme di valori farà da modello nell’immaginazione poetica a varie isole, tra cui non è possibile dimenticare la metamorfosi letteraria di Itaca nella Zacinto di Foscolo, in un poeta pur sempre ‘greco’:
Né mai più toccherò le sacre sponde
Ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell’onde
del greco mar da cui vergine nacque
Venere, e fea quelle isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue frondi
l’inclito verso di colui che l’acque
cantò fatali, e il diverso esiglio
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio,
O materna mia terra; a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.

Come Foscolo stesso dice, Zacinto non è taciuta da Omero. È Ulisse a citarla associandola ad Itaca, quando finalmente si presenta con la sua vera identità ai Feaci in 9, vv. 21-36, in un brano che immediatamente precede il racconto che come un aedo rivolge ad Alcinoo e ai membri della reggia; in questi versi omerici esiste già quel quell’immaginario poetico che associa Itaca in quanto patria ἀγαθὴ κουροτρόφος ai valori della maternità, genitorialità, al femminile, in contrapposizione a quelli declinati al maschile presenti nel sonetto foscoliano. Doveva essere proprio questo specifico passo ‘l’inclito verso di colui che l’acque cantò fatali’ da cui trasse ispirazione Foscolo, ma il cui rapporto col testo foscoliano è stato spesso dai critici trascurato o sottaciuto, o, semplicemente, dimenticato.
Il distacco dalla patria e l’esilio, che però produce il racconto epico di Ulisse ai Feaci, come il canto del figlio in Foscolo, già in Omero è percepito in maniera implicita come se fosse un distacco dal ventre materno e dai genitori e così deve averlo letto un altro lettore di Omero: appunto il Capitano Ugo Foscolo:
Abito a Itaca chiara nel sole: in essa è un monte
che spicca, il Nerito frusciante di foglie; intorno sono
molte isole, vicine tra loro,
Dulichio e Same e Zacinto selvosa (= ‘ le tue frondi’ di Foscolo).
Bassa nel mare essa giace, ultima
verso occidente – le altre a parte, verso l’aurora e il sole –,
irta di sassi (‘le tue limpide nubi’, Itaca è avvolta dalle nubi per volere di Atena nel canto 13 e non è reale), ma brava nutrice di giovani (ἀγαθὴ κουροτρόφος = ‘materna mia terra’ di Foscolo). Non so vedere
altra cosa più dolce, per uno, della sua terra.
… scil. Calipso, Circe (altre isole) lo tenevano nella loro dimora,
mai nessuna però convinse nel petto il mio animo.
Perché niente è più dolce, per uno, della patria
e dei suoi genitori, anche se abita una casa opulenta
lontano, in terra straniera, diviso dai genitori.
Mentre Zacinto, in virtù delle memorie greche omeriche e odissiache, trapassa questa volta dalla storia al mito e dal mito alla poesia, dal mondo reale a quello letterario, quindi ad un immaginario mai più raggiungibile per il poeta in esilio, Itaca continua a palpitare trasfigurata nella Zacinto foscoliana, inverandosi ancora in una forma nuova ma sempre coerente con gli antichi valori.