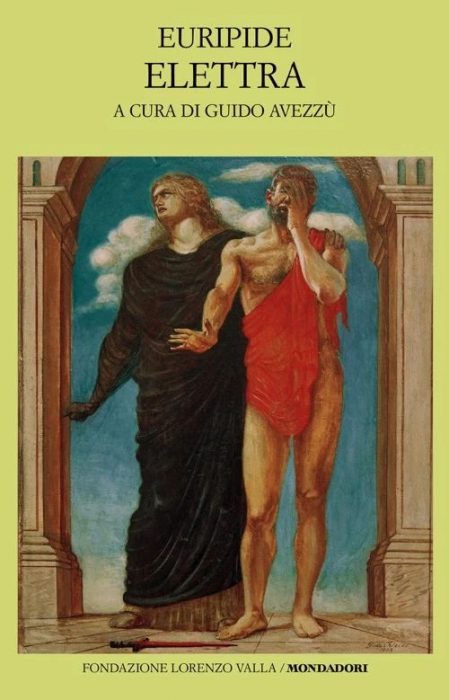Filippomaria Pontani, Il Sole 24 Ore
Una mattina di mezza estate di quasi duemila anni fa, il retore Dione di Prusa (orazione 52) si alzò, fece un giro all’ippodromo e una passeggiata, tornò a casa, si lavò e dopo una breve colazione si mise a leggere i tre drammi dedicati al mito di Filottete da Eschilo, Sofocle, Euripide. A noi, dopo il naufragio quasi integrale della produzione teatrale attica, una simile esperienza comparativa è data solo conte Coefore di Eschilo e le Elettre degli altri due tragici, che coprono la stessa storia mitica: irresistibile, da sempre, la tentazione di fare classifiche e trinciare giudizi. In questo gioco a premi l’Elettra di Euripide – conservata per un accidente del destino assieme a un manipolo di tragedie disposte in ordine alfabetico, e stampata per ultima nel 1545 (forse per infondati sospetti di inautenticità) – ha avuto di norma la peggio, venendo canzonata per i suoi incongrui melismi già da Aristofane nelle Rane, per la sua dubbia efficacia dal filosofo Filodemo di Gadara (molti gli elementi sospesi tra il realismo e il comico), e dai moderni per la sua cervellotica singolarità («un raro esempio di insensatezza poetica», la crocifisse August Schlegel).
Guido Avezzù produce ora quella che è (sia detto con la debita ammirazione per l’asciutto nitore di J.D. Denniston, Oxford 1939) la migliore edizione di questo dramma disponibile worldwide: la migliore anzitutto perché esce dal suddetto schema agonistico, tratta sobriamente e senza ossessioni gli irrisolti e secolari problemi critici (la data; la cronologia relativa rispetto all’Elettra di Sofocle; la presunta “contestazione implicita” delle Coefore), sottolinea lapregnanza dei dialoghi pur così semplici e colloquiali, e prova a dipanare iuxta propria principia il dedalo di riconoscimenti, discorsi falsi, messe alla prova (si avverte l’Odissea, con tanto di cicatrice risolutiva), che menano al doppio assassinio di Egisto e di Clitennestra da parte dei fratelli Oreste ed Elettra,veri protagonisti del dramma. Un’Elettra nevrotica, autoriferita, interamente proiettata nel passato; un’ambizione, che per lungo tratto si diffrange in false identità e torna se stesso solo per uccidere e perdere la pace.
Tra l’introduzione e il commento, Avezzù prova a dare concretamente “vita” a un capolavoro scenico che manca di alta poesia, ma e poi anche dai moderni per la sua cervellotica singolarità adotta scelte rivoluzionarie, la più importante delle quali (in un testo dove tutto è giocato tra il “fuori” e il “dentro”) è il setting agreste presso la modesta casupola dove Elettra vive con suo marito, un contadino che per rispetto l’ha lasciata vergine. Niente regge di Argo o di Micene: questo consorte autourgòs («colui che fa le cose da sé», come ire omerici che cucinano e lavano i panni) è bensì un penes («uno che fatica», traduce etimologicamente Avezzù al v. 253), ma incarna l’ideale euripideo secondo cui la virtù non conosce distinzioni di classe: e, benché alla fine spodestato da Pilade, cui Elettra sarà affidata da Castore, è lui, un povero, uno di quelli «che nessuno vuole per amici» (v. 1131), il vincitore morale tra i cocci di una stirpe nobile e maledetta.
La traduzione, solida, elude le sirene degli endecasillabi di Diano o di Pontani senior, anche se la pazzoide prima monodia di Elettra va sparare (v.166) in un tornito «ed ebbe nel suo letto un traditore». Si opta qui per un dettato scabro, talora reticente (a 15 thely thalos «germoglio gentile» mantene l’allitterazione ma perde il connotato di genere, «femminile»; a 688 kear è il petto, il cuore, non il «fianco»; ai.o23 Agamennone taglia non la «gola bianca» ma la «gota bianca» di Ifigenia, dettaglio indispensabile per apprezzare la speculare supplica estrema di Clitennestra che — narra Oreste a 1216 — «alle mie gote si aggrappava» prima di soccombere). Talora subentrano sovrainterpretazioni (259 «o straniero» diventa «tu non lo sai»; 419 «la disgraziata» diventa «ed è capace di tutto»; 1170 il coro rincara su Clitennestra morente «ma l’hai voluto», che nel greco non c’è), talaltra faticose prolessi (27 «Ucciderla, questo avrebbe voluto»; 41 «il sangue l’avrebbe svegliato», dove soggetto è l’uomo, ma non s’intende).
Di un libro così importante, impreziosito da una Nota al testo che è la più aggiornata e attendibile sintesi sulla storia della trasmissione delle tragedie euripidee, si auspica una ristampa che sani le sviste di greco, asciughi un apparato critico non sempre nitido, e induca ripensamenti là dove l’editore ha preferito in solitaria lezioni impossibili (vv. 281, 657). Il commento tocca il vertice nelle sezioni corali, di cui dirime con maestria struttura, movenze musicali, suture linguistiche e narrative; in generale, esamina con grande cura la questione cruciale e onnipresente dell’attribuzione delle battute. Forse si poteva qua e là premere di più sull’intertestualità. «E ora che facciamo?» dice Oreste alla vigilia dell’atto supremo (967), alludendo alla celebre esitazione dinanzi al seno nudo della madre nelle Coefore, ma forse anche all’urlo disperato dei figli di Medea che dalla madre vengono sgozzati (1271; il lamento di Oreste alv.1176 ricalca quello del coro in Medea 1252)? La lode di Agamennone «condottiero della Grecia, non inferiore a Egisto» (1081) non ricorderà quella tributata da Saffo al fratello Menelao nell’ode ad Afrodite: Quando Elettra raccomanda con falsa premura a Clitennestra, appena entrata in casa sua, «che i muri fumosi non ti lordino gli abiti» (1140), nor avrà presente le remore del padre che si scalza per non sporcare il tappeto purpureo nella scena-clou dell’Agamennone? «Sarai felice, libero da queste pene», l’ultimo verso dell’azione non ricalca l’incipit dello stesso Agamennone (la scolta che chiede agli dèi “la liberazione da queste pene”)? E soprattutto, quando la vergine Elettra canta inconsolabile «In lacrime veglio la notte» (v. 181, un dakrysi nycheuo compatto e raro), sarà un «lessico assente negli altri tragici» oppure un doloroso rinvio per antifrasi all’Eros che «veglia sulle morbide gote di uni fanciulla» (ennycheuei, gergo militare da sentinella) nell’inno ad Eros delI’Antigone sofoclea (784)?