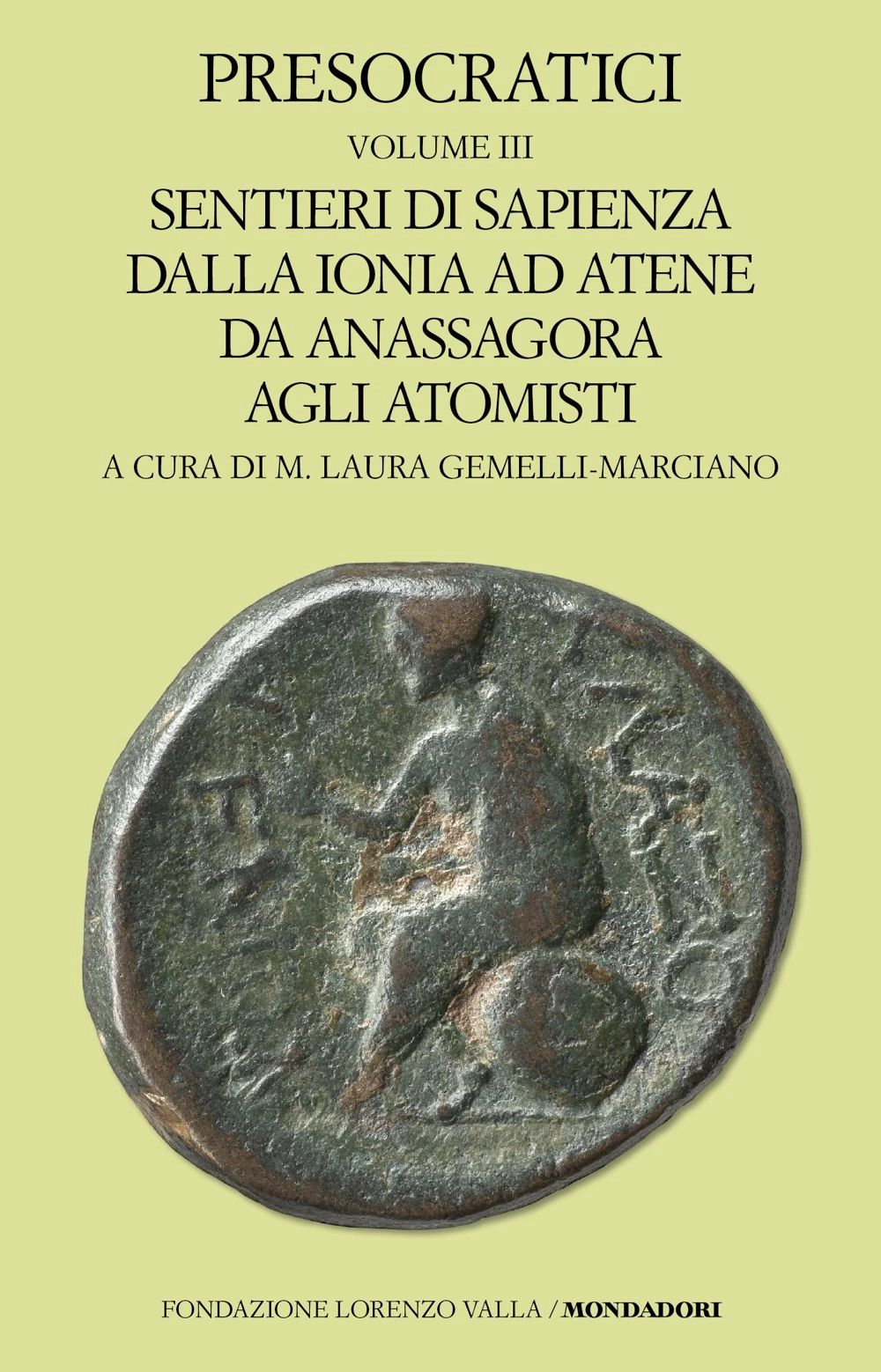In questo terzo e ultimo volume i “sentieri di sapienza” convergono in Atene e nelle città entrate, volenti o nolenti, nella sua orbita. In un’atmosfera caratterizzata soprattutto dall’amore per il discorso “intelligente” e il parlare “brillante” negli ambienti aristocratici ruotanti intorno a Pericle, non c’è spazio per una sapienza del tipo di quella magno-greca, orientata ai bisogni concreti degli individui e delle comunità in tutte le loro declinazioni e radicata in tradizioni e pratiche esoteriche. C’è, invece, terreno fertile per uno sviluppo in direzione decisamente più astratta e speculativa di una “filosofia” della natura di matrice ionica depurata da ogni suo legame con il contesto socio-culturale in cui era sorta e dalle sue finalità pratiche. Decisivo in questo senso è l’arrivo nella città, probabilmente nel secondo quarto del V sec. a.C., di Anassagora di Clazomene, il meteorologos (filosofo della natura) per eccellenza e abile retore, accolto come un maestro da Pericle. Infatti, qualche decennio più tardi, nel contesto delle lotte di potere fra eterie aristocratiche, gli avversari di quest’ultimo, per colpirlo indirettamente, trascinano in processo con l’accusa di empietà proprio “lo straniero” Anassagora: costui avrebbe studiato i fenomeni celesti (la cosiddetta meteorologia), dominio degli dèi, e affermato che il sole, un corpo divino, è solo una pietra incandescente. Il filosofo, a quanto sembra, è costretto a fuggire dalla città e torna sulla costa ionica, a Lampsaco, dove muore intorno al 428 a.C.

L’accusa di empietà contro Anassagora è favorità, però, anche dall’alone di sospetto che circonda le azioni di altri stranieri in possesso di una sapienza di ben più pratica applicazione. Infatti, i testi letterari dell’epoca recano tracce della presenza in Atene, come in altre città della Grecia, dei cosiddetti magoi, guaritori carismatici con poteri straordinari che, proprio per il loro particolare rapporto con gli dèi, sarebbero in grado non solo di guarire l’epilessia, ma anche di governare a piacimento i fenomeni naturali. Così li presenta, ovviamente con intento denigratorio, il medico ippocratico, autore del trattato Sulla malattia sacra (l’epilessia, appunto), nel suo potente attacco contro questi temibili concorrenti. L’opinione comune non operava alcuna distinzione fra il meteorologos e questi personaggi che, evidentemente possedevano anch’essi, sebbene in un’altra ottica e con altri intenti, conoscenze approfondite della natura del cosmo e della biologia umana (l’esempio di Empedocle è un caso chiaro di carismatico-guaritore di questo tipo). Nell’Ateniese medio sorgeva, dunque, naturale il sospetto che anche il meteorologos potesse sfruttare le sue conoscenze “delle cose di sopra” per manipolare le divinità e i fenomeni ed esercitare la magia a detrimento dei propri concittadini. Del resto, anche la rappresentazione di Anassagora nell’epitafio inciso sulla sua tomba dai Lampsaceni rimanda un’immagine ambigua, fra realtà e metafora, del filosofo della natura che “viaggia” fino ai confini estremi del cosmo celeste accomunandolo indirettamente ai viaggi estatici e alle azioni prodigiose dei carismatici. In Atene, per dissipare i sospetti sulla figura del meteorologos, seguaci e sostenitori sviluppano una contro-narrazione, presupposta in alcuni testi dell’ultimo terzo del V sec. a.C. e ripresa poi anche nelle rappresentazioni platoniche e aristoteliche: il filosofo della natura non ha alcun interesse per le azioni pratiche, ma si dedica unicamente alla contemplazione della natura e dell’ordine celeste senza alcun intento di manipolare o di nuocere. Il ritratto del filosofo speculativo, focalizzato sulla theoria e disinteressato alla pratica si è imposto come modello nell’antichità e persiste ancora nell’immaginario dei nostri giorni.
Il libro di Anassagora, che presenta chiare tracce di oralità, si configura come la fissazione scritta di una conferenza tenuta davanti a un pubblico colto. La sua tesi cosmogonica e cosmologica parte da due punti fermi: una mescolanza corporea indistinta in cui tutto si trova in tutto, nella cosa più grande come in quella più piccola, e il nous, un intelletto ordinatore, anch’esso corporeo, sebbene di un corpo sottile. Questi comincia a separare le masse cosmiche imprimendo alla mescolanza indistinta un moto vorticoso e continua all’infinito la sua opera di separazione e di distinzione. In questo modo, siccome anche del più piccolo c’è sempre un più piccolo, il mondo non può inabissarsi nel non essere. Su queste basi si sviluppa una narrazione del cosmo e delle sue componenti, talvolta assai poco chiara, ma retoricamente potente come deve essere il discorso del meteorologos che fa apparire l’invisibile davanti agli occhi del pubblico.

In questo volume è incluso anche Melisso di Samo, il generale che avrebbe sconfitto nel 441 a.C. in una battaglia navale la flotta di Pericle prima che quest’ultimo conquistasse definitivamente l’isola. Più giovane di Anassagora di qualche decennio, Melisso viene normalmente inserito fra gli Eleati nelle edizioni dei presocratici. In realtà, nonostante le apparenti somiglianze, è profondamente distante dalla linea di Parmenide e non è “figlio” suo come invece era, anche formalmente per adozione, Zenone; conosce certamente il poema parmenideo, ma ne è ben lontano per origine, spirito e scopo. Mentre Parmenide riporta il suo poema e la sua “scienza” alla rivelazione della dea che lo ha condotto all’esperienza dell’È e addita a una cerchia ristretta di iniziati una via lontana da quelle battute dagli uomini, Melisso è il sapiente ionico che esibisce le sue doti dialettiche cercando di dimostrare una tesi provocatoria e paradossale, ma servendosi nel contempo di concetti e argomenti consueti e ben familiari ai suoi ascoltatori. Qualche esempio: Melisso parte dal principio parmenideo secondo cui nulla si genera dal nulla. Ciò che è è ingenerato perché, in caso contrario, avrebbe dovuto essere generato da un non essere preesistente, ma nulla nasce dal nulla; essendo tale, ciò che è sempre era e sempre sarà. Questa formulazione, che attribuisce esistenza all’essere nel passato e nel futuro è del tutto estranea alla lingua e all’essenza dell’insegnamento della dea di Parmenide la quale afferma: «e mai era né sarà, poiché è ora, tutto insieme, / uno, continuo» (Gemelli-Marciano II, Parmenide, 15, 10-1). Per lei le forme verbali del passato e del futuro esprimono nel contempo essere e non essere come tutte le denominazioni umane: il “ciò che è” di Parmenide non è eterno perché esiste prima e dopo, ma perché si trova in un “ora” senza tempo e solo in quanto tale può essere sperimentato. È evidente che Melisso non è passato attraverso questa esperienza dell’È come uno “stato” eterno e presente, ma si limita a darne una definizione concettuale umana, basandosi sulle tradizionali “formule di eternità”. Per lo stesso motivo, afferma, in chiaro contrasto con gli insegnamenti parmenidei, che ciò che è è illimitato perché non ha né inizio né fine.

Per Parmenide, infatti, è vero il contrario: l’È, proprio perché è ingenerato ed eterno, è limitato, perfetto; se così non fosse, sarebbe imperfetto (Gemelli-Marciano II, Parmenide, 15, 35-8; 47-54). Anche su questo punto Melisso fa dunque capo alla tradizione ionica, alla concezione dell’apeiron, l’illimitato spazio-temporale di Anassimandro (Gemelli-Marciano I, 8 A-C). C’è inoltre, un altro elemento, sempre equivocato dai commentatori antichi e moderni: in Parmenide, l’uno dell’È è cursoriamente menzionato insieme ad altri “segni” e non è concepito come quantità, ma come uno stato di perfezione in cui cade ogni distinzione. L’insegnamento della dea non si accentra sull’uno, ma sull’esperienza di questa particolare condizione di assoluta perfezione, unità, continuità e omogeneità sperimentabile nell’“ora” ed esclude ogni tipo di differenza. Melisso concettualizza, invece, questo stato trasformandolo, come poi Platone, Aristotele e tutti gli altri autori antichi, in una “cosa” quantitativamente unica e illimitata come risulta dall’argomento (non parmenideo) portato a sostegno di questa illimitatezza: ciò che è è uno perché, se fosse due cose, queste non potrebbero essere illimitate, ma si limiterebbero a vicenda. Nei testi di fine V-inizio IV sec. a.C. è Melisso, non Parmenide, ad essere menzionato come monista.
Interessante, per le sue strette correlazioni con i testi dei medici ippocratici degli ultimi decenni del V sec. a.C., è, invece, Diogene di Apollonia (colonia di Mileto, l’attuale Sozopol in Bulgaria), un autore di cui non si sa assolutamente nulla. Anche la sua datazione esatta rimane incerta, affidata com’è ad allusioni alla dottrina dell’aria nelle commedie di Aristofane e nei testi ippocratici di fine V sec. a.C. Questa dottrina era, infatti, piuttosto diffusa al tempo e, soprattutto, giocava un ruolo anche nella fisica di Archelao, ateniese e discepolo di Anassagora.

Diogene definisce la sua opera una syngraphe, uno scritto in prosa, specificando quali ne debbano essere le caratteristiche; punta, dunque, come Tucidide e Democrito, a una comunicazione attraverso il libro, non attraverso la conferenza orale destinata all’ascolto, rivolgendosi a un pubblico che ha il sostrato culturale e le capacità per recepirla in questa forma. L’impostazione biologica della sua dottrina cosmologica, la sua attenzione alla biologia e, soprattutto, la descrizione molto dettagliata del sistema venoso, un cui parallelo è attestato solo presso due medici di fine V-inizio IV sec. a.C., non solo rivelano conoscenze mediche specialistiche, ma inducono a pensare che i suoi principali destinatari fossero appunto medici e profani colti con interessi in campo medico, gli stessi a cui sono diretti alcuni trattati ippocratici di fine V secolo a.C.
I frammenti di Diogene si incentrano sull’assunto, non ulteriormente dimostrato, secondo cui le innumerevoli forme che appaiono diverse fra loro sono manifestazioni di un unico sostrato comune. Quest’ultimo, per essere tale, deve possedere una forza divina smisurata, essere presente dovunque ed essere fonte di vita e intelligenza. L’aria che, secondo Diogene, soddisfa tutti questi requisiti, è il principio presente in diversi gradi in tutte le cose e quello dalla cui alterazione e metamorfosi derivano i fenomeni e gli esseri viventi. La cosmologia e la biologia di Diogene sono basate inoltre sull’idea che tutti i corpi, quelli celesti, quelli inanimati e quelli degli esseri viventi, in quanto derivanti dalla stessa sostanza, presentino un’affinità di fondo, abbiano la stessa struttura e sottostiano agli stessi processi naturali. Tutti, non solo i più leggeri e porosi come quelli celesti, ma anche i più duri come la terra, il ferro e il magnete, sono attraversati da un sistema di canali che permette una vera e propria “respirazione” come anche il passaggio da una parte all’altra dell’aria, dell’umidità e dei fluidi. Come per i medici del suo tempo, anche per Diogene, dunque, il mondo e gli esseri animati e inanimati che lo popolano riflettono la struttura e le dinamiche del corpo umano sul quale egli sembra incentrare in particolare la sua ricerca.
Degli atomisti antichi, Leucippo (figura sfuggente, di datazione e provenienza incerta) e il suo discepolo Democrito, sono rimasti per lo più solo scarsi frammenti e resoconti indiretti nonostante l’immensa produzione scritta di quest’ultimo. Ciò è dovuto, in parte, allo sviluppo di altre forme di atomismo (quello dell’Accademia platonica e, soprattutto, quello epicureo) che hanno soppiantato le dottrine più antiche influenzandone anche le relative interpretazioni. Al naufragio ha inoltre contribuito non poco la lingua democritea, molto complessa e ricca di termini con significati particolari tanto che, già alla fine del III sec. a.C., Callimaco, il bibliotecario di Alessandria, ha sentito il bisogno di comporne un lessico. Le opere di Democrito, non solo quelle sui principi e la cosmologia, ma anche e soprattutto quelle tecniche, sono a poco a poco sparite dall’orizzonte dei lettori colti dopo l’età ellenistica nonostante la fama del filosofo. Da tutto questo deriva la necessità, imprescindibile per l’editore, dell’analisi accurata delle fonti e dei presupposti che ne hanno determinato le interpretazioni.

Democrito è di Abdera, colonia ionica nella Tracia assorbita da Atene nella sua area di influenza dopo il 477 a.C. La sua data di nascita oscilla fra il 470 e il 460 a.C. e quella di morte cade nei primi decenni del IV sec. a.C. È dunque un contemporaneo di Socrate, ma la sua dottrina atomistica non sembra essere penetrata in Atene prima della seconda metà del IV sec. a.C. quando viene discussa probabilmente dagli allievi di Platone nell’ambito della problematica delle grandezze indivisibili matematiche come limite ultimo della divisione dei corpi e utilizzata, nello stesso contesto, da Aristotele e dai suoi discepoli in funzione antiplatonica.
Proprio nel quadro della critica aristotelica alle teorie accademiche sugli indivisibili, in particolare nella Metafisica e nei trattati di fisica, l’atomismo democriteo assume un aspetto più nettamente matematizzante rispetto alla dottrina originale. Viene infatti presentato come il risultato di una riflessione teorica sul problema della divisibilità all’infinito come quello accademico, una prospettiva che ha influenzato poi le interpretazioni antiche e moderne. Aristotele, però, aveva trattato l’atomismo antico anche in un’opera specifica su Democrito della quale è arrivato un solo frammento proprio sui principî e sulla maniera in cui essi generano il mondo e i corpi in esso presenti. Qui, in un’esposizione relativamente libera dal sostrato teorico e anche dal lessico presente nei passi argomentativi (basti pensare che non vi compare il termine atomon) è sottolineata in particolare la compattezza e la solidità dei corpi primi (vengono chiamati infatti nasta, come certe focacce dure e farcite) che garantiscono, proprio per questa loro indistruttibilità, il fondamento della generazione e del rinnovamento incessante dei mondi e dei corpi composti. Questi ultimi, invece, in quanto contenenti vuoti di varie forme e dimensioni, sono, in diversa misura, vulnerabili ed esposti continuamente all’azione di forze interne ed esterne destabilizzanti e distruttive che li portano infine alla disgregazione negli elementi originari; da questi ricomincia un nuovo ciclo di aggregazioni. Qui, come anche nel resoconto sulla cosmogonia atomistica attribuita a Leucippo, le forme atomiche non sono concepite per risolvere problema teorico della divisibilità all’infinito. Non sono dunque unità ultime, matematiche, tutte uguali a cui deve necessariamente arrestarsi il processo di divisione mentale, ma entità corporee in continuo movimento e di forme infinite, irregolari e diversissime, pensate per intrecciarsi, combinarsi e comporre corpi reali.
La cosmogonia atomistica presenta inoltre un sostrato di immagini profondamente influenzate dalla biologia e dall’embriologia presente anche nei testi ippocratici contemporanei; a concezioni mediche correnti rimandano anche le parti dell’opera democritea più strettamente attinenti alla biologia. È necessario, dunque, porsi anche da un’ottica rovesciata il problema degli influssi che, invece, la critica moderna ha quasi unanimemente risolto assegnando la preminenza alle tesi democritee. Non sempre è così; talvolta è Democrito ad aver attinto a dottrine mediche, talvolta sia lui che gli autori ippocratici fanno capo a un sostrato medico comune.

Un importante tassello per una visione più globale e completa della produzione libraria democritea e della sua figura di erudito a tutto campo (e non solo di filosofo della natura) è costituito dai titoli delle sue opere riportati nel catalogo di Trasillo, astrologo e grammatico greco-egizio alla corte di Tiberio. Il catalogo ci rimanda, infatti, l’immagine di un polymathes dell’ultimo terzo del V e dei primi decenni del IV sec. a.C., esperto di ogni genere di saperi specialistici dall’astronomia, alla medicina, all’agricoltura, all’arte della guerra. Questo sostrato emerge anche nei resoconti dossografici e negli scarsi frammenti superstiti e costituisce una buona base per una nuova interpretazione dell’atomismo antico.
L’esegesi di Democrito, così come quella dei “sapienti” che lo hanno preceduto, necessita di revisioni che tengano conto di tutte le sfaccettature della sua opera, ma anche del contesto politico-culturale in cui essa è sorta. Questo aspetto si riflette in particolare nei frammenti etici, giunti in numero molto superiore al resto, ma anche nelle immagini legate alla natura e alle dinamiche dei corpi primi e dei corpi composti. Incroci, intersezioni di piani e ambiti diversi, analisi dettagliata delle fonti, ma anche del contesto culturale e geografico in cui egli ha svolto la sua attività dovrebbero d’ora in poi costituire la base per interpretazioni di Democrito che spingano lo sguardo oltre l’angusto orizzonte delle sue dottrine “filosofiche”.